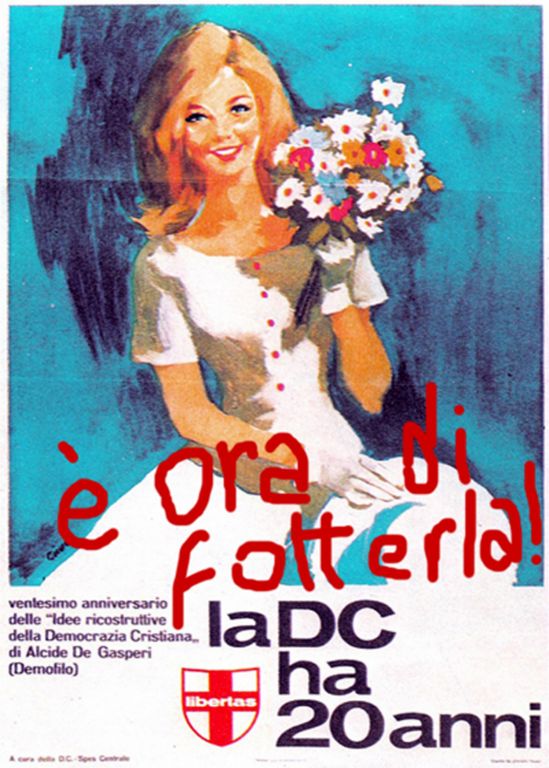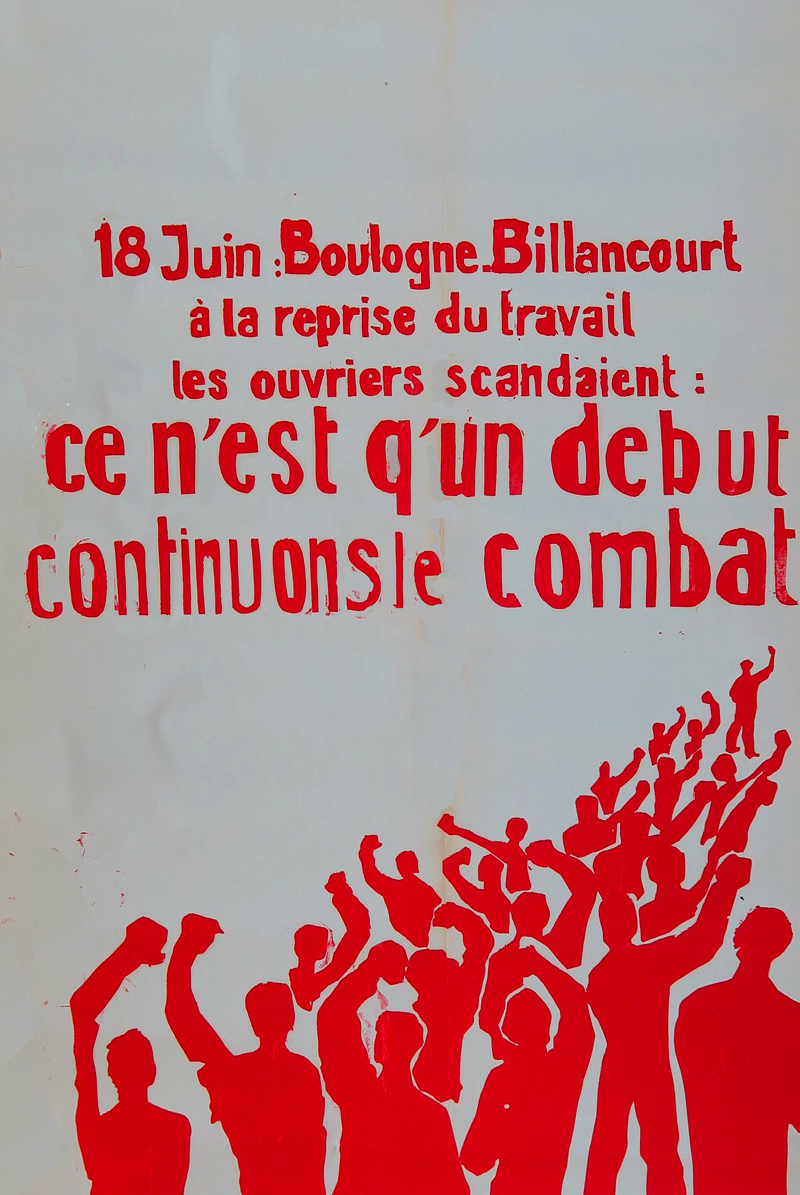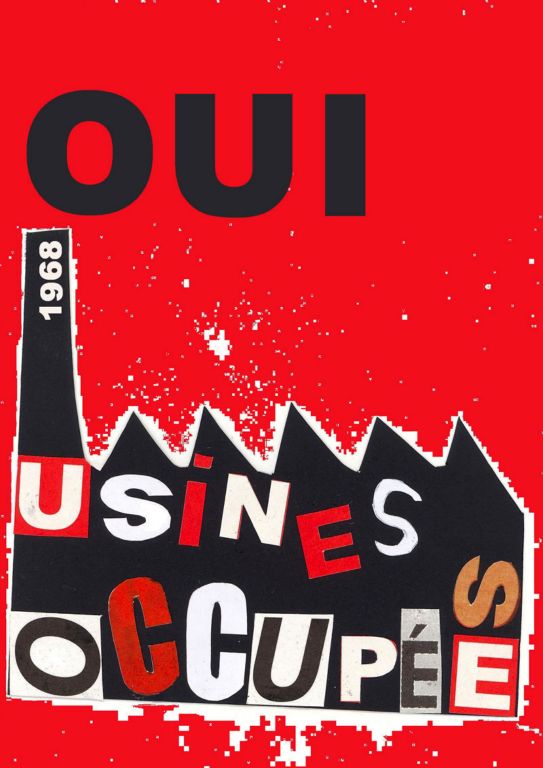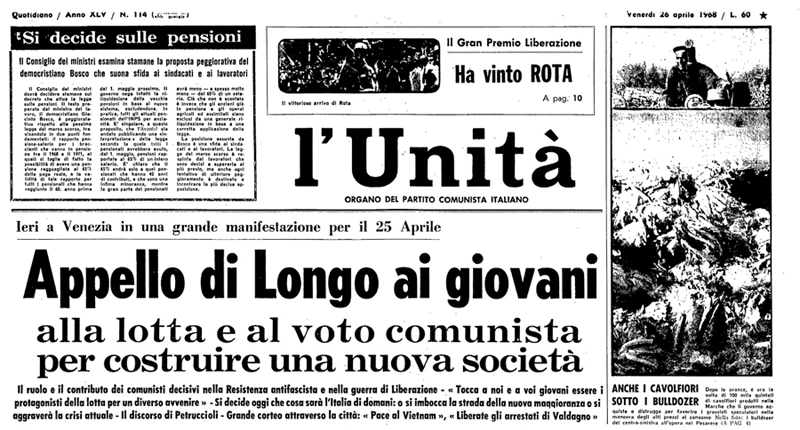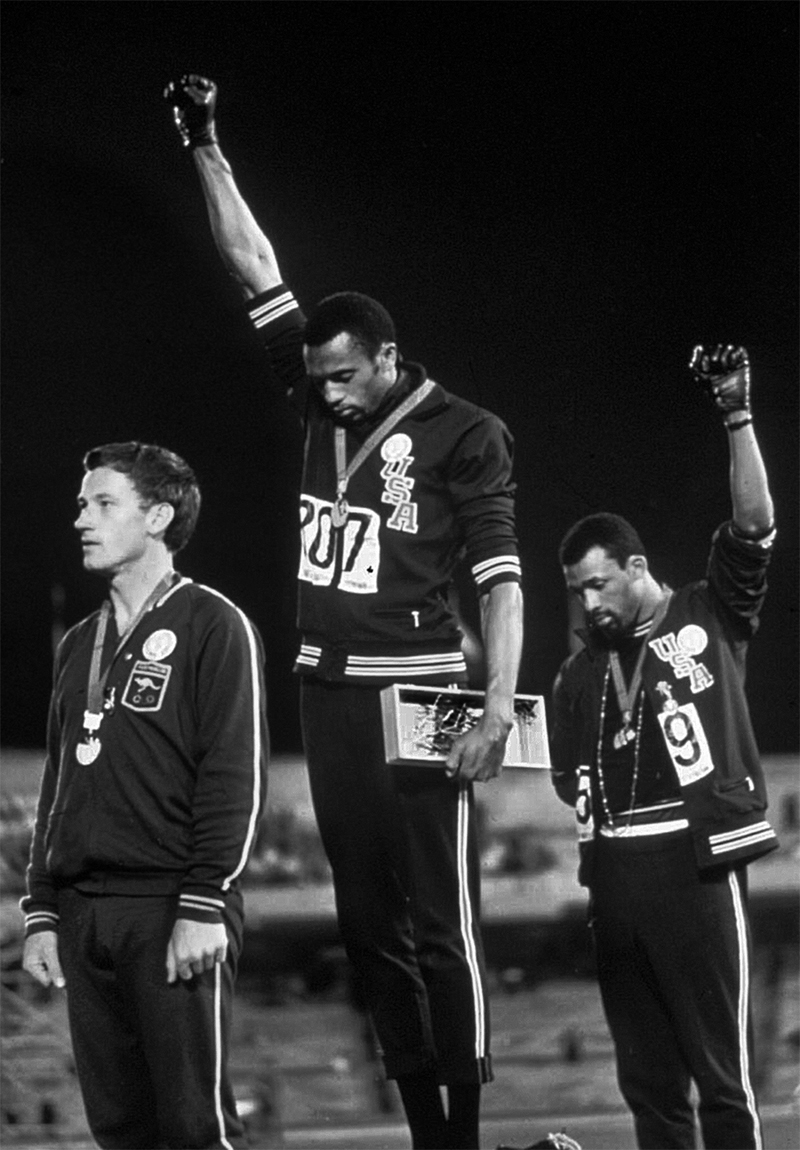BREVE STORIA D'ITALIA
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
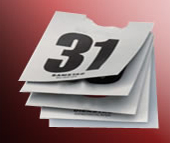 |
 |

altro : cronologia - immagini - cinema - espresso - micromega - millennium - cercando il '68 - appunto
Qualcuno ebbe a dire che il celebre maggio francese era in verità
cominciato a Trento, parecchi mesi prima, nell’autunno
del 1967 (per una ricostruzione della sequenza degli avvenimenti, v. la cronologia)
proprio nei giorni in cui Ernesto Che Guevara stava combattendo la sua ultima battaglia prima di essere catturato
e ucciso dall’esercito boliviano (col supporto della CIA).
Naturalmente non ha molta importanza attribuire certificati di
paternità: in realtà in Italia, in Francia, in Germania,
in altri paesi europei, fra i giovani si respirava già
da tempo un’aria nuova. La contestazione degli hippies di San Francisco, nei primi anni ‘60, verso la guerra in Vietnam aveva coinvolto parti significative dell’avanguardia
intellettuale americana ma gli echi della beat
generation di Jack Kerouac (il suo On
the road, Sulla strada, rimase per anni forse il libro più
amato dai giovani, così come le canzoni di Bob Dylan e
Joan Baez; in realtà lo spirito anarchico di Kerouac era
in contrasto con le sue posizioni strettamente politiche, decisamente
più conservatrici di quanto i suoi lettori pensassero)
e di Allen Ginsberg erano giunti in Europa affievoliti,
deformati da un clima culturale completamente diverso: qui nella
prima metà del decennio si guardava piuttosto ai Beatles
e ai Rolling Stones, si portavano i capelli lunghi o i pantaloni
scampanati, con un certo disappunto da parte dei benpensanti e
tuttavia senza turbare la sostanza dell’ordine costituito;
questo vago, e tutto sommato innocuo (schegge di televisione ci
fanno ancora vedere certe trasmissioni RAI affollate da giocondi
“capelloni” impegnati a seguire ritmi musicali più
o meno plausibili) anticonformismo, lentamente in vari settori
del mondo giovanile si trasformò in un disagio sempre più
marcato nei confronti di società che venivano viste come
dominate da valori vecchi, e nell’università ciò
prese la forma di un discorso tutto politico.
In alcune Facoltà spuntarono - accanto
ai classici del marxismo - testi
di studiosi finora conosciuti solo da pochi addetti ai lavori,
Herbert Marcuse,
Theodor W. Adorno, Wilhelm Reich, Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Paul Sweezy, Eric
Fromm, e altri ancora.

Su questa solida e diffusa tradizione marxista, dunque, si innestò la protesta studentesca: da Trento, Pisa e Milano si diffuse a Torino, a Roma e poi praticamente in tutti gli Atenei, ed ebbe il suo momento di svolta il 1° marzo 1968, quando gli studenti romani che volevano occupare di nuovo la facoltà di Architettura, appena sgombrata dalla Questura, per la prima volta risposero alle cariche della polizia e ingaggiarono, a Valle Giulia, una vera e propria battaglia di piazza.
Così scrisse Pier Paolo Pasolini sull’Espresso (n. 24, 16.6.68), in uno dei suoi tanti e bellissimi scritti corsari, consapevolmente contraddittori, segnati da un bruciante desiderio di capire e al tempo stesso di non farsi intrappolare dalla pigrizia degli schemi.
Tutto il sistema formativo italiano era basato su un ordine culturale e legislativo costruito a fine ‘800 e in epoca fascista, e conteneva in sé tutti gli elementi più deteriori dell’Italietta: norme arcaiche e confuse, totale mancanza di democrazia e trasparenza, disorganizzazione, inadeguatezza delle strutture, carenza nei servizi primari (a cominciare dalle aule), metodi e percorsi di studio sorpassati, libri di testo ottocenteschi, carenza della ricerca scientifica. Può essere indicativo lo scarso numero di premi Nobel ottenuti da italiani: Golgi (1906), Marconi (1909), Fermi (1938), Segrè (1959), Natta (1963), Luria (1969), Dulbecco (1975) - Segrè, Luria e Dulbecco erano però diventati cittadini statunitensi - Rubbia (1984), Levi Montalcini (1986). Altri Nobel, per la letteratura: Carducci (1906), Deledda (1926), Pirandello (1934), Quasimodo (1959), Montale (1965), Fo (1997).
Anche nell’università (dove oltre a tutto i professori erano spesso latitanti), come in genere nei vari servizi pubblici, gli utenti principali, cioè gli studenti, erano insomma considerati poco più che un inevitabile fastidio, ma la protesta andò immediatamente oltre questi aspetti, diciamo così, organizzativi e divenne dissenso radicale verso il ruolo stesso esercitato dalla scuola: questa, in estrema sintesi, veniva considerata un vero e proprio mezzo di manipolazione ideologica, attraverso il quale le classi dominanti formavano generazioni pronte a inserirsi disciplinatamente nel sistema capitalistico; l’università, in particolare, aveva la funzione di preparare i quadri dirigenti della collettività e in quanto tale era criticata ancora più pesantemente.
Ma, proprio per tale intima connessione fra istruzione e società, gli studenti dovevano trovare “un corretto rapporto fra lotta sulle strutture universitarie e tensione non estremistica a porsi anche all’esterno come forza attiva [...perché] il solco tra movimento studentesco e movimento operaio non va approfondito ma criticamente scavalcato se si vuole che la funzione critica del movimento studentesco non operi nel vuoto”. (Alberto Asor Rosa, Lotte studentesche e movimento operaio, in Problemi del Socialismo, n. 28-29, marzo-aprile 1968) “Noi nelle metropoli combattiamo contro il complesso delle istituzioni che ci dominano, in cui gli uomini debbono essere giorno e notte condizionati per garantire la conservazione dell’ordine costituito. Ognuno deve restare integrato, deve essere oggetto degli oggetti dominanti: altrimenti tutto il sistema ne viene rivoluzionato.” (Rudi Dutschke, Teoria e pratica in situazioni specifiche, Feltrinelli, 1968, p. 32. Dutschke era il principale leader degli studenti tedeschi: durante una manifestazione gli spararono alla testa e il giornale conservatore Der Spiegel ironizzò finemente sul fatto che egli, agonizzante, invocasse la madre)

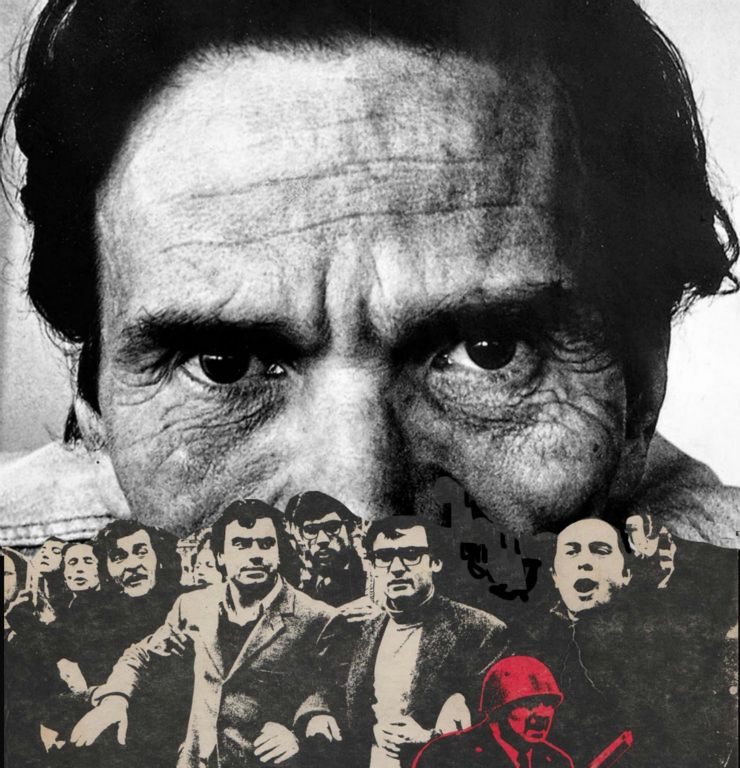

Dopo circa un anno dalle prime occupazioni (in cui si chiedeva innanzi tutto il diritto di assemblea) il movimento studentesco non esisteva praticamente più in quanto corpo omogeneo: lo spiccato carattere ideologico assunto dal dibattito aveva portato alla frammentazione in vari gruppi, genericamente detti della “sinistra extraparlamentare”: è molto difficile dar conto di questa realtà variegata (per una panoramica v. nelvento), sia perché in tutte le formazioni vi furono ripetutamente spaccature, ricomposizioni, fusioni, sia perché la loro evoluzione fu estremamente rapida, e segnata da una fortissima competitività reciproca. In ogni modo questi gruppi sono riconducibili principalmente a due filoni del pensiero marxista: quello comunista e quello più legato all’elaborazione antileninista di Rosa Luxemburg, e, in Italia, all’esperienza maturata nella sinistra socialista e in riviste come Quaderni Rossi, di Raniero Panzieri.
Nel primo caso il riferimento ideologico era la Cina, e in particolare la Rivoluzione culturale promossa da Mao nel 1966: i comunisti cinesi avevano rotto con Mosca nel 1964, accusando i sovietici di revisionismo, cioè di aver tradito i princìpi del marxismo-leninismo rivedendone i punti centrali e criticando Stalin; a metà degli anni ‘60 in Europa si erano staccati dai partiti comunisti piccoli nuclei che nel nome stesso intesero ribadire la loro fedeltà al marxismo-leninismo di Mao e Stalin, ma restarono sostanzialmente insignificanti: da noi il PCd’I m-l (Partito Comunista d’Italia marxista-leninista) era una realtà microscopica, che addirittura si spaccò in due partitini concorrenti, ciascuno impegnato più a farsi “riconoscere” da Pechino o da Tirana (!) che a fare politica; tra gli studenti ebbe invece una notevole fortuna l’Unione dei comunisti m-l (più conosciuta col nome del suo giornale Servire il popolo), con la sua grande rigidità dottrinaria, i cortei all’insegna del libretto rosso di Mao e del più ridicolo realismo socialista (per realismo socialista s’intende più specificamente la concezione - nata nell’URSS degli anni ‘30 e diffusasi poi nei regimi cosiddetti socialisti - dell’arte come rappresentazione esclusiva della “realtà”, in cui naturalmente predominavano muscolosi operai e coraggiose donne che celebravano entusiasticamente le vittorie proletarie).
Con analoghe simpatie per Mao, ma con minor folklore e con seria
attenzione verso il PCI (che comunque mantenne viva la propria
presenza, ancorché minoritaria rispetto ai gruppi, sia
nelle scuole che nelle università), il gruppo guidato a
Milano da Mario Capanna, e che mantenne il nome
di Movimento Studentesco. Con posizioni di forte
radicalità, in cui pesavano anche elementi delle teorie
trotskiste, Avanguardia Operaia. Tutt’altro
che vicino al dogmatismo m-l, ma con dichiarate simpatie
verso la rivoluzione culturale, il Manifesto,
creato da dirigenti del PCI (Pintor,
Rossanda, Magri, Castellina) radiati all’inizio
del ‘69 per le loro aspre critiche al funzionamento del
partito e ai suoi ritardi nell’elaborazione teorica; nel
‘71 fondarono l’omonimo quotidiano, che rimase in
vita (a differenza di quelli creati da Lotta Continua
e Avanguardia Operaia) anche dopo la scomparsa del gruppo.
Più vivaci sul piano dell’iniziativa e politicamente
più articolate (proprio perché assai meno incardinate
a rigidi presupposti ideologici) le formazioni che non si rifacevano
direttamente alla tradizione del movimento operaio: con una struttura
per certi versi simile ai gruppi m-l, ma senza alcun richiamo
alla matrice stalinista, Potere Operaio, l’organizzazione
costituita da Toni Negri e Oreste Scalzone (maScalzone lo chiamavamo).
Lotta Continua fu una delle formazioni che ebbe maggior seguito,
e oltre i confini scolastici, anche perché meno di altre
ebbe la preoccupazione di darsi un forte assetto ideologico e
organizzativo (ricordo ancora la perentoria affermazione di un
dirigente di Lotta Continua, durante una delle innumerevoli assemblee
universitarie in cui noi comunisti venivamo regolarmente battuti
dai gruppi: “Il marxismo non si studia, si applica!”)
e puntò invece a calarsi in tutte le aree di più
acuta conflittualità e marginalità sociale, dal
movimento di occupazione delle case ai fermenti di protesta nelle
carceri e nelle caserme, fino ad appoggiare la stessa rivolta
di Reggio Calabria. In seguito all’assegnazione a Catanzaro
del ruolo di Capoluogo di Regione (1970), si creò un violento
movimento di protesta che per più di un anno agitò
la vita di Reggio C. Furono alcuni gruppi di potere locale e il
MSI ad alimentare quella che in talune occasioni assunse le caratteristiche
di ribellione sociale: fu proprio su questo aspetto che LC tentò,
inutilmente, di innestare elementi politici in grado di trasformare
una generica lotta localistica in rivolta popolare.
Al di là delle notevoli differenze fra i vari gruppi (intorno
ai principali ne proliferò una miriade di minor consistenza),
si può sommariamente rilevare che l’impianto estremista
delle loro analisi e proposte si fondava su una visione del tutto
semplicistica sia della composizione di classe della società
italiana, assai più complessa della mera contrapposizione
borghesia-proletariato, sia dei rapporti di forza fra le parti
in conflitto, che andavano ben al di là della rispettiva
consistenza “militare”. Tant’è che già
nei primi anni ‘70 la maggior parte di queste formazioni
non esisteva più o si era disarticolata prendendo le strade
più varie: i marxisti-leninisti semplicemente scomparvero;
una parte di LC e di Potere Operaio confluì nella cosiddetta
area dell’Autonomia, a sua volta poi frantumatasi, un’altra,
minoritaria, andò ad alimentare le file del terrorismo;
il movimento di Capanna tentò di riorganizzarsi oltre l’ambito
universitario e in seguito fu una delle componenti di Democrazia
Proletaria; il Manifesto si unì a una parte del disciolto
PSIUP, costituendo il PdUP, mentre il quotidiano
rimase come entità autonoma; molti militanti entrarono
in ordine sparso nel PCI, altri, più proficuamente dal
punto di vista economico, nel PSI o direttamente in qualche grande
azienda.
Alle elezioni del 1972 il PSIUP ottenne un risultato fallimentare,
non riuscendo a eleggere nessun parlamentare: la maggioranza decise
di sciogliere il partito e confluire nel PCI, la minoranza formò
il PdUP (Partito di Unità Proletaria); l’alleanza
elettorale (1975-6) fra PdUP, Avanguardia Operaia e Movimento
Lavoratori per il Socialismo (il gruppo di Capanna), prese il
nome di Nuova Sinistra Unita e successivamente (1978) si costituì
in partito (senza però il gruppo dirigente del PdUP, che
entrò nel PCI): Democrazia Proletaria si è poi sciolta nel 1991, con alcuni suoi dirigenti, fra
cui Capanna, entrati nel movimento ambientalista, mentre la maggioranza
ha aderito a Rifondazione Comunista.
Parentesi: ma che fine hanno fatto tanti "rivoluzionari" che quotidianamente ricoprivano di merda il PCI?



Oltre a cinema, teatro, letteratura, musica, di cui si parlerà
più avanti, è significativo come settori importanti
del mondo scientifico furono portati a interrogarsi sul proprio
ruolo: medici, psichiatri, magistrati, proprio in quegli anni
diedero vita a forme associative di netto orientamento progressista.
Rossana Rossanda definì il 68 l’anno degli
studenti, ed in parte è senz’altro vero,
ma questa espressione fu coniata durante le giornate più
calde del maggio studentesco e non poteva raccogliere l’altra
novità di enorme importanza che si stava delineando, cioè
l’energico rilancio della combattività operaia.
Già nel 1966, col rinnovo contrattuale degli elettromeccanici,
si era capito che le lotte di pochi anni prima non erano state
un sussulto isolato e che il paziente lavoro di ricucitura del
rapporto fra sindacato e lavoratori cominciava a dare i primi
risultati.
Ancora una volta furono i giovani operai meridionali a dar fuoco
alle polveri. Le trasformazioni nell’organizzazione industriale,
in particolare con l’introduzione di nuovi sistemi di controllo
della produttività (tra cui le famose tabelle in cui i capireparto segnavano scrupolosamente i tempi e la qualità
delle prestazioni dei dipendenti), avevano comportato un notevole
appesantimento delle condizioni di lavoro, con ritmi particolarmente
faticosi, precarietà in termini di sicurezza e salute,
e il continuo ricatto del cottimo, cioè il salario direttamente
in proporzione alla quantità di produzione effettuata.
In numerose fabbriche del Nord si diffuse un accentuato malcontento
fra i lavoratori, ma gli organismi sindacali, le Commissioni Interne,
erano molto prudenti e ritenevano che i rapporti di forza col
padronato non fossero ancora tali da consentire una ripresa delle
lotte.
Così il sindacato indirizzò la propria iniziativa
su alcuni temi d’interesse generale (la casa,
le pensioni), organizzando scioperi e manifestazioni:
si trattò certamente di una scelta importante, perché,
oltre a portare all’attenzione dei cittadini questioni di
rilevante peso sociale, riproponeva un confronto politico sulle
grandi riforme, e tuttavia rischiava di riprodurre il vecchio
errore degli anni ‘50, quando la strategia elaborata a livello
centralizzato aveva perso di vista le realtà specifiche.
Quando gruppi di operai organizzarono spontaneamente improvvise
fermate del lavoro, cortei interni alle aziende, volantinaggi
fuori dai cancelli, i sindacati presero le distanze da queste
azioni considerate avventate, oltre a tutto valutando che non
avrebbero avuto un gran seguito: invece, soprattutto in alcuni
grandi stabilimenti (Pirelli, Fiat Mirafiori, Alfa Romeo, Petrolchimico
di Marghera, Siemens, Magneti Marelli), queste lotte spontanee
presero piede a tal punto che in molti casi le Commissioni Interne
furono completamente tagliate fuori; i gruppi, e in particolare
Lotta Continua, cominciarono a intervenire sistematicamente di
fronte alle fabbriche e riuscirono in diverse situazioni a creare
nuovi organismi, i Comitati Unitari di Base, che per un certo
periodo ottennero larghi consensi.

Ci fu naturalmente chi, a sinistra e a destra, si affrettò a stilare il necrologio del sindacato, ma la tradizione del movimento operaio italiano non era fatta di retorica, bensì di legami profondi di solidarietà e di cultura politica: la ricchezza di tale patrimonio, e l’intelligenza di molti dirigenti sindacali (primo fra tutti Bruno Trentin, allora Segretario della FIOM CGIL), consentì al sindacato di recuperare rapidamente il terreno perduto e di riprendere in mano la direzione del movimento. Gradualmente le vecchie Commissioni Interne vennero sostituite dai Consigli di fabbrica, o più precisamente dei delegati, perché in ogni reparto i lavoratori eleggevano un proprio delegato, indipendentemente dal sindacato di appartenenza, che li avrebbe rappresentati nel Consiglio unitario di azienda.


Alla ripresa dell’attività dopo le ferie del 1969, CGIL, CISL e UIL, che nel frattempo
avevano avviato fra loro un intenso dialogo di riavvicinamento,
erano pronte a un’offensiva che si rivelò ancora
più ampia del previsto: la lotta per il rinnovo del contratto vide la partecipazione di oltre un milione e mezzo di metalmeccanici,
a cui si unirono quasi tutti i lavoratori degli altri comparti,
consapevoli del significato politico che avrebbe assunto l’esito
dello scontro. Questo autunno caldo finì con la conquista
di quasi tutte le rivendicazioni (aumenti di salario
uguali per tutti, introduzione graduale delle 40 ore
settimanali, diritto di assemblea, abolizione
delle gabbie salariali, cioè delle differenti
retribuzioni fra zone e zone) e spianò la strada ai rinnovi
contrattuali che nei mesi successivi videro impegnati,
con analogo successo, i chimici, gli edili, i ferrovieri, i tessili,
e le categorie del pubblico impiego.
Questo nuovo clima fra l’altro favorì in modo decisivo
l’approvazione dello Statuto
dei lavoratori: per la prima volta una Legge dello
Stato disciplinava rigorosamente i diritti dei lavoratori dipendenti,
sancendo alcune libertà e principi fondamentali altrimenti
sottoposti al completo arbitrio dei datori di lavoro. Non si può
non vedere il nesso tra lotte operaie e studentesche, creatosi
anche al di là degli specifici obiettivi di lotta. Si era
avviato un processo di liberazione che coinvolgeva nel profondo
la società e nell’insieme si può dire che
il 68 fu molto di più che una stagione politica: incrinò
vecchie regole, mise in discussione mentalità sorpassate,
e soprattutto liberò una molteplicità di energie
senza le quali la società sarebbe sicuramente meno dinamica
e aperta.
Il 1968, tuttavia, fu un anno cruciale anche a causa dei fatti
di Cecoslovacchia: nel partito comunista di quel
paese si era andato formando un nuovo gruppo dirigente, che voleva
risolutamente avviare una politica di riforme che chiudesse col
passato stalinista.



Così si espresse Enrico Berlinguer al XII Congresso del PCI (1969): “Il nostro modo di collocarci di fronte a questa realtà dei paesi socialisti [...] non è più venato di elementi mitici, ma affidato per intero alla capacità critica e al rigore rivoluzionario.”

- La migliore bibliografia: in appendice all'imponente e bellissimo libro curato da Giampaolo Borghello, Cercando il '68, Udine, Forum, 2012
- Bibliografia ragionata (2008) a cura della Biblioteca comunale di Bellinzona
in generale
1968 un anno dai mille volti, in l'Europeo, gennaio 2008
1968: un anno di confine: i fotografi italiani raccontano, in l'Europeo, 2008
• 1968: dizionario della memoria, il Manifesto libri, 1988, 2008
A. Agosti - L. Passerini - N. Tranfaglia (cur.), La
cultura e i luoghi del '68, Angeli, 1990
Hanna Arendt, Politica e menzogna, Comunità, 1985
Raymond Aron, La rivoluzione introvabile, Rubettino, 2 008
• Alberto Asor Rosa, Lotte studentesche e movimento operaio,
in Problemi del Socialismo, n. 28-29, marzo-aprile 1968
Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, Feltrinelli, 1971
Nanni Balestrini - P. Moroni, L’orda d’oro, Sugarco,
1988
Franco Basaglia - Franca Basaglia Ongaro, La maggioranza deviante,
Einaudi, 1971
• Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, Einaudi,
1970
U. Bergmann - R. Dutschke - W. Lefevre, La ribellione degli
studenti, Feltrinelli, 1968
Riccardo Bertoncelli, Un sogno americano. Storia della musica
Pop, Arcana, 1975
Giorgio Boatti, Piazza Fontana. 12 dicembre 1969: il giorno dell'innocenza
perduta, Feltrinelli, 1993
A. Bolaffi - E. De Luca, Come noi coi fantasmi. Lettere sull'anno
sessantottesimo del secolo tra due che erano giovani un tempo,
Bompiani, 1998
• Giampaolo Borghello (cur.), Cercando il '68 : documenti, cronache, analisi, memorie : antologia, Forum, 2012
Anna Bravo, A colpi di cuore, Laterza, 2008
Massimo Cacciari, Dopo l'autunno caldo: ristrutturazione e analisi
di classe, Marsilio, 1973
• Mario Capanna, Formidabili quegli anni, Rizzoli,
1988
Mario Capanna, Lettera a mio figlio sul 68, Rizzoli, 1998
Toni Capuozzo,
Andare per i luoghi del '68, il Mulino, 2018
Valerio Castronovo (cur.), L'Italia contemporanea 1945-1975, Einaudi,
1976
• Noam Chomsky, I nuovi mandarini: gli intellettuali e il
potere in America, Einaudi, 1969
Pablo Echaurren, Parole ribelli: '68 e dintorni, Stampa Alternativa,
1998
Franco Ferrarotti, Il 68 quarant'anni dopo, EdUp, 2008
• M. Flores - A. De Bernardi, II Sessantotto, iI
Mulino, 1988
Paolo Flores d'Arcais, II maggio rosso di Parigi, Marsilio, 1968
A. Gigliobianco - M. Salvati, Il maggio francese e l’autunno
caldo italiano, il Mulino, 1980
• Paul Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi,
Einaudi, 1989, 2007
Fulvio Grimaldi, Un sessantotto lungo una vita, Zambon, 2018
Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991: l'età dei
grandi cataclismi, Rizzoli, 1995
Augusto Illuminati, Percorsi del '68: il lato oscuro della forza, Derive/Approdi, 2008
• Henri Lefébvre, Critica della vita quotidiana,
Dedalo, 1977
Malcolm X, Autobiografia, Einaudi, 1967
Herbert Marcuse, Oltre l’uomo a una dimensione, Manifestolibri, 2015
• Micromega, Sessantotto!, n. 1-2, 2018
Mino Monicelli, L'ultrasinistra in Italia 1968-1978, Laterza,
1978
Adriano Mordenti, Come eravamo, Samonà e Savelli, 1970
Raul Mordenti, Frammenti di un discorso politico, Essedue, 1989
nelvento.net/archivio/68/
Peppino Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America, 1988
Franco Piperno, Il '68: l'anno che ritorna, Rizzoli, 2008
Fernanda Pivano, Amici scrittori: 40 anni di incontri e scoperte
con gli autori americani, Mondadori, 1994
Wilhelm Reich, La rivoluzione sessuale, Feltrinelli, 1963
Wilhelm Reich - Eric Fromm, Contro la morale borghese, Samonà
e Savelli, 1972
Marco Revelli, Movimenti sociali e spazio politico, in: Storia dell'Italia
repubblicana, v. 2, Einaudi, 1995
Rossana Rossanda, L'anno degli studenti, De Donato, 1968
E. Scalfari - G. Turani, Razza Padrona, Feltrinelli, 1974
Sessantotto, in: Millennium, n. 6, 2017
Leoncarlo Settimelli, Il '68 cantato, Zona, 2008
Adriano Sofri, II '68 e il Potere operaio pisano, Massari, 1998
Storia d'Italia, Einaudi, 1972- 6
La strage di stato, Samonà e Savelli, 1970; Avvenimenti, 1993
Marica Tolomelli, Il Sessantotto: una breve storia, Carocci, 2008
Giuseppe Vettori, La sinistra extraparlamentare in italia, N. Compton, 1973
Guido Viale, Giorno dopo giorno. 1968-2018: 50 anni di nuovi inizi, Mimesis, 2018
Guido Viale, II sessantotto, Mazzotta, 1978
Guido Viale, Il '68 : contro l'Università e il sessantotto tra rivoluzione e restaurazione, Interno4, 2018
internazionale
John Lee Anderson, Che Guevara, una vita rivoluzionaria, Baldini
& Castoldi, 1997
Jack Belden, La Cina scuote il mondo, Laterza, 1971
Giovanni Blumer, La rivoluzione culturale cinese (1965-67), Feltrinelli,
1969
Stokeley Carmichael - Charles V. Hamilton, Strategia del Potere
Negro, Laterza, 1968
Jerome Ch'En, Mao Tse-tung e la rivoluzione cinese, Sansoni, 1966
Enrica Collotti Pischel, Le origini ideologiche della rivoluzione
cinese, Einaudi, 1979
• Enrica Collotti Pischel, Storia della rivoluzione cinese,
Ed. Riuniti, 1972, 1992
Furio Colombo, L’America di Kennedy, Feltrinelli, 1964
Jean Daubier, Storia della rivoluzione culturale proletaria in Cina,
Jaca Book, 1972
Angela Davis, Nel ventre del mostro, Ed. Riuniti, 1971
Alexander Dubcek, Il nuovo corso in Cecoslovacchia, Ed. Riuniti, 1968
• Frantz Fanon, I dannati della terra, Einaudi, 1969
• Vo Nguyên Giap, Guerra di popolo, Ed. Riuniti, 1968
Ernesto Guevara, Diario in Bolivia, Milano, Feltrinelli, 1997
• Ernesto Guevara, La guerra di guerriglia, Feltrinelli, 1966
Ernesto Guevara, Opere, Feltrinelli, 1968
Ho-Chi-Minh, Lo spirito del Vietnam, Ed. Riuniti, 1968
• Leo Huberman - Paul M. Sweezy, La controrivoluzione globale,
Einaudi, 1968
Martin L. King, La forza di amare, SEI, 1967
William Hinton, La guerra dei cento giorni. Rivoluzione culturale e
studenti in Cina, Einaudi, 1975
Le Duan, La rivoluzione vietnamita, Ed. Riuniti, 1971
Malcolm X, Autobiografia, Einaudi, 1967
Mao Tse-tung, Per la rivoluzione culturale. Scritti e discorsi
inediti 1917-1969, Einaudi, 1975
J. Myrdal - G. Kessle, Un villaggio cinese nella rivoluzione culturale, Einaudi, 1972
Bobby Seale, Cogliere l'occasione!, Einaudi, 1971
Edgar Snow, La lunga rivoluzione, Einaudi, 1974
Edgar Snow, Stella rossa sulla Cina, Einaudi, 1974
Paco I. Taibo II, Senza perdere la tenerezza. Vita e morte di Che
Guevara, Milano,1997
Giuseppe Vettori, La sinistra extraparlamentare in Italia, Newton Compton, 1976
• Arnulf Zitelman, Non mi piegherete: vita di Martin Luther
King, Feltrinelli, 1997
scuola
Documenti dell'occupazione del Liceo Parini, Feltrinelli, 1968
Michele Gesualdi (cur.), Don Lorenzo Milani maestro di libertà,
Firenze, 1987
Roberto Mazzetti, Lettera a una professoressa e i suoi problemi,
Morano, 1972
Lorenzo Milani, L'obbedienza non è più una virtù,
Libreria Editrice fiorentina, 1965
Edgar Morin, Sociologia del presente, Ed. Lavoro, 1987
• Peppino Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e
in America, Ed. Riuniti, 1988
Marco Revelli, Movimenti sociali e spazio politico, in: Storia dell'Italia
repubblicana, Einaudi, 1995
• Rossana Rossanda, L'anno degli studenti, De Donato, 1969
• Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa,
Libreria Editrice fiorentina, 1967
Guido Viale, Il sessantotto. Tra rivoluzione e restaurazione,
Mazzotta, 1978
lotte
sindacali
• Aris Accornero, La parabola del sindacato, il
Mulino, 1992
• Aris Accornero (cur.), Problemi del movimento sindacale in Italia: 1943-1973, Feltrinelli, 1976
• Detlev Albers, Breve storia del movimento sindacale in Italia,
ESI, 1975
Romano Alquati, Sulla FIAT e altri scritti, Feltrinelli, 1974
L’autunno caldo dieci anni dopo 1969-1979, Lerici, 1979
Guido Baglioni, Il sindacato dell’autonomia, De Donato,
1977
Adriano Ballone, Uomini, fabbrica e potere, Angeli, 1987
Pietro Bellasi, Fabbrica e società. Autogestione e partecipazione
operaia in Europa, Angeli, 1972
Emanuele Bevilacqua, Battuti e Beati, Einaudi, 1996
G. Cella - B. Manghi - P. Piva, Un sindacato italiano negli anni
’60: la Fim-Cisl, De Donato, 1973
Ciclo capitalistico e lotte operaie: Montedison, Pirelli, Fiat,
Marsilio, 1969
I Comitati Unitari di Base: origini sviluppo prospettive, Sapere,
1973
Consigli operai e consigli di fabbrica: l’esperienza consiliare
dalle origini ad oggi, Savelli, 1978
Fabrizio D’Agostini, La condizione operaia e i consigli di fabbrica,
Ed. Riuniti, 1975
La democrazia nel sindacato, Mazzotta, 1975
• Vittorio Foa, Sindacati e lotte operaie 1943 - 1973,
Loescher, 1976
A. Forbice - R. Chiaberge, Il sindacato dei consigli, Bertani,
1974
Pio Galli, Da una parte sola, Manifesto libri, 1997
Gino Giugni, Il sindacato tra contratti e riforme, De Donato,
1973
D. Grisoni - H. Portelli, Le lotte operaie in Italia dal 1960
al 1976, Rizzoli, 1977
Liliana Lanzardo, Cronaca della commissione operaia del movimento studentesco
torinese, Centro di Documentazione di Pistoia, 1998
Liliana Lanzardo, Personalità operaia e coscienza di classe,
Angeli, 1989
Gian Giacomo Migone, Stati Uniti, Fiat e repressione antioperaia negli anni cinquanta, Loescher, 1974
• Franco Momigliano (cur.), Lavoratori e sindacati di fronte alle trasformazioni del sistema produttivo, Feltrinelli, 1962
Operaismo e centralità operaia, Ed. Riuniti, 1978
Raniero Panzieri, Lotte operaie nello sviluppo capitalistico,
Einaudi, 1976
Edgardo Pellegrini, L’ondata operaia reclama il potere, Samonà
e Savelli, 1969
Alessandro Pizzorno (cur.), Lotte operaie e sindacato in Italia (1968-1972),
il Mulino, 1974
Potere Operaio (cur.), Porto Marghera - Montedison estate 68,
Centro Francovich di Firenze, 1968
Emilio Pugno - Sergio Garavini,
Gli anni duri alla FIAT, Einaudi, 1974
I. Regalia - M. Regini, Sindacato e relazioni industriali, in:
Storia dell’Italia repubblicana, v. 3, Einaudi, 1993
Marino Regini, I dilemmi del sindacato, il Mulino, 1981
M. Regini - E. Reyneri, Lotte operaie e organizzazione del lavoro,
Marsilio, 1971
Marco Revelli, Lavorare in Fiat, Garzanti, 1989
Vittorio Rieser, Fabbrica oggi: lo strano caso del dottor Weber
e di mister Marx, Sisifo, 1992
Giovanni Russo (cur.), L’egemonia operaia. Ricostruzione di un
dibattito, Cappelli, 1978
Marianella Sclavi, Lotta di classe e organizzazione operaia, Mazzotta,
1974
Sull’operaismo, Praxis, 1973
Nicola Tranfaglia (cur.), Crisi sociale e mutamento dei valori. L‘Italia
negli anni 60 e 70, Tirrenia, 1989
• Bruno Trentin, Autunno caldo. Il secondo biennio rosso (1968-1969), Ed. Riuniti, 1999
• Bruno Trentin, Da sfruttati a produttori, De
Donato, 1977
Bruno Trentin, Il sindacato dei consigli, Ed. Riuniti, 1980
Mario Tronti, Operai e capitale, Einaudi, 1971
• Sergio Turone, Storia del sindacato in Italia dal 1943
ad oggi, Laterza, 1984, 1992
marxismo
e dintorni
Theodor W. Adorno e altri, La personalità autoritaria,
Comunità, 1973
Lucio Colletti, Ideologia e società, Laterza, 1969
Critica della tolleranza, Einaudi, 1968
Umberto Galeazzi, La
scuola di Francoforte, Città Nuova, 1975
Carlo Galli, Alcune interpretazioni italiane della Scuola di Francoforte,
in: il Mulino, n. 228, 1973
Jürgen Habermas (cur.), Risposte a Marcuse, Laterza, 1969
• M. Horkheimer - T. W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo,
Einaudi, 1976
M. Horkheimer, E. Fromm, H. Marcuse, Studi sull’autorità
e la famiglia, Utet, 1973
Herbert Marcuse, Eros e civiltà, Einaudi, 1964
Herbert Marcuse, Marxismo e rivoluzione, Einaudi, 1975
• Herbert Marcuse, L’uomo a una dimensione,
Einaudi, 1967
Herbert Marcuse, Logica dell’utopia, Laterza, 1968
Herbert Marcuse, Saggio sulla liberazione, Einaudi, 1969
Tito Perlini, Che cosa ha veramente detto Marcuse, Ubaldini, 1970
A. Schmidt - G. E. Rusconi, La scuola di Francoforte. Origini
e significato attuale, De Donato, 1972
emigrazione
F. Alberoni - G. Baglioni, L'integrazione dell'immigrato nella
società industriale, il Mulino, 1965
Ugo Ascoli, Movimenti migratori in Italia, il Mulino, 1979
Corrado Barberis, Le migrazioni rurali in Italia, Feltrinelli, 1960
Paolo Cinanni, Emigrazione e unità operaia, Feltrinelli,
1972
Goffredo Fofi, L'immigrazione meridionale a Torino, Feltrinelli,
1964
Antonio Golini, Le migrazioni interne in: Storia d'Italia, Einaudi,
1972-6
Teresa Isenburg, Il trend demografico degli ultimi cento anni, in:
Storia d'Italia, Einaudi, 1972-6
Giovanni Pellicciari (cur.), L'immigrazione nel triangolo industriale,
Angeli, 1970
Nuto Revelli, Il mondo dei vinti, Einaudi, 1977
Salvatore F. Romano, Le classi sociali in Italia dal Medioevo all'età
contemporanea, Einaudi, 1977
cinema
• Marco Bellocchio, La Cina è vicina, 1967
• Jean-Luc Godard, La Cinese, 1967
• Dennis Hopper, Easy Rider, 1969
• Arthur Penn, Alice's Restaurant, 1969
• Gruppo Dziga Vertov, Lotte in Italia, 1970
• Stuart Hagmann, Fragole e sangue, 1970
• Ettore Scola, Dramma della gelosia, 1970
• Michael Wadleigh, Woodstock - Tre giorni di pace, amore e musica, 1970
• Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, 1970
• Elio Petri, La classe operaia va in paradiso, 1971
• Jean-Luc Godard, Crepa padrone, tutto va bene, 1972
• Paolo Pietrangeli, Porci con le ali, 1977
• Miloš Forman, Hair, 1979
• Bernardo Bertolucci, The Dreamers - I sognatori, 2003
• Marco Tullio Giordana, La meglio gioventù, 2003
• Philippe Garrel, Les Amants réguliers, 2005
• Julie Taymor, Across the Universe, 2007
• Michele Placido, Il grande sogno, 2009